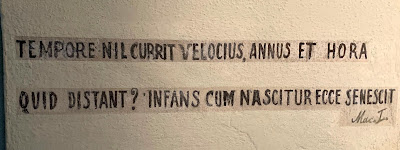domenica 2 febbraio 2025 - Sensi e Sensazioni
L’antico San Benedetto in Polirone è legato al monastero benedettino fondato nel 1007 da Tedaldo di Canossa sull’isola che sorgeva tra il Po e il Lirone, un ramo del grande fiume oggi scomparso. Si entra in San Benedetto dall’ingresso del monastero, che conserva i cardini dell’antico portale, e la piazza maestosa, rimasta intatta nelle dimensioni che aveva nel medioevo e intitolata a Teofilo Folengo, inventore del latino maccheronico, apre le sue braccia al visitatore, col monastero e i tesori artistici della chiesa abbaziale che scontano l’ira e lo sbeffeggio dei contadini, obbligati a contribuire al sostentamento dei monaci.
Ma qui, grazie all’opera laboriosa di quei monaci che hanno bonificato e coltivato il territorio consentendo produzioni d’eccellenza, si è creata l’agricoltura più importante d’Italia
Il nonno della contessa Matilde, fonda il monastero per creare dei possedimenti fortificati che avrebbero garantito sicurezza e fedeltà.
Nel 1077, Matilde di Canossa dona l’abbazia a Gregorio VII: il papa la unisce al monastero di Cluny in Borgogna, dando a quest’ultimo il potere di nominare l’abate di Polirone; il cenobio mantovano aumenta l’attività di miniatura, costruisce chiese e chiostri, acquista terre, diventando una sorta di Cluny dell’Italia settentrionale.
Nel 1420, grazie all’abate Guido Gonzaga il monastero entra nella congregazione benedettina di Santa Giustina di Padova rinnovandosi nell’edilizia, nell’economia, nella cultura e assumendo la struttura che conserva ancora oggi; i monaci intraprendono riforme agrarie e opere di bonifica, ma obbligano i coloni a consegnare loro un terzo del raccolto.
Nel XVI secolo, l’abbazia diviene un attivo centro intellettuale, promuovendo non solo gli studi teologici, ma anche la cultura artistica: i monaci commissionano lavori al Correggio e a Giulio Romano, e ospitano personalità illustri quali Martin Lutero, Paolo III, Giorgio Vasari, Torquato Tasso e Palladio.
Nel 1609, una rovinosa inondazione del Po provoca danni ingenti al monastero, cui si sommano, vent’anni dopo, quelli provocati dagli eserciti stranieri di passaggio.
Nel XVIII secolo, il governo illuminato di Maria Teresa d’Austria porta a una modesta ripresa economica venendo incontro alle esigenze dei contadini, mentre l’ultimo abate Mauro Mauri promuove una serie di interventi importanti per evitare la soppressione del monastero, che si avrà comunque, nel 1797, con l’arrivo delle truppe napoleoniche; il patrimonio artistico si disperde, ad eccezione di quello della chiesa abbaziale e dei preziosi manoscritti confluiti nella biblioteca di Mantova.
L'abbazia ebbe un ruolo fondamentale nella storia del monachesimo italiano ed europeo, tanto da essere definita "la Montecassino del nord".
La basilica abbaziale ci accoglie con la sua imponenza e la meravigliosa architettura che disegnò il genio di Giulio Romano, tra il 1540 e il 1545, riedificando - senza demolirle - le vecchie strutture romaniche e gotiche, e adottando soluzioni originali per far convivere i diversi stili architettonici in un insieme raffinato e omogeneo.
Le 32 statue di santi che arredano le navate e ornano gli ingressi delle cappelle laterali sono opera (1542-59) di Antonio Begarelli, artista modenese definito dal Vasari “il Michelangelo della terracotta”. Nell’ambiente tra il transetto e la sagrestia si trova la tomba di Matilde di Canossa, un sarcofago in alabastro sorretto da quattro leoncini di marmo rosso, ma il corpo di Matilde riposa dal 1633 nella basilica di San Pietro a Roma.
Antecedente alla morte della contessa è l’Oratorio di Santa Maria (fine XI - metà XII secolo), che è stato poi adattato alla chiesa maggiore nel momento della sua riedificazione (1130), secondo lo schema dell’oratorio di Santa Maria di Cluny.
Il Chiostro dei Secolari, dove venivano accolti i pellegrini, gli ospiti e i forestieri è caratterizzato da tre fasi costruttive: una anteriore al XV secolo, un’altra databile 1475 e infine quella del 1674, epoca di costruzione del scenografico Scalone secentesco realizzato da Giovan Battista Barberini.
Un luogo molto suggestivo è il Chiostro di San Simeone in stile tardogotico, databile tra il 1458 e il 1480, dove si trovava il giardino dei semplici con le erbe medicinali per curare i malati. Sul chiostro si affaccia la sala del Capitolo, vero e proprio centro direttivo del cenobio.
Il terzo Chiostro, dedicato a San Benedetto e adiacente a un fianco della basilica, fu ricostruito intorno al 1450 nell’ambito del rinnovamento architettonico di Polirone sostenuto da Guido Gonzaga. Il lato meridionale fu assorbito nella basilica da Giulio Romano per edificare le cappelle di sinistra.
Sulla Piazza Matilde di Canossa si affaccia anche il refettorio monastico, costruito nel 1478.
A due passi dalla chiesa abbaziale, si trova il Campanile romanico di San Floriano, appartenente all’antica chiesa parrocchiale, ora demolita. Fino alla soppressione del monastero, San Floriano era la chiesa per il popolo, mentre la basilica, collocata all’interno della cittadella monastica, era a uso esclusivo dei monaci.
Usciti dal monastero, si sente subito la vicinanza del grande fiume, che scorre lento e possente, e ancora navigabile. In questa periferia del nulla, come qualcuno vorrebbe chiamarla, si ha la sorpresa di trovare un paesaggio che si perde nei silenzi della campagna, costellata di oratori, ville abbaziali, pievi matildiche, caseifici e corti agricole.